I miei giorni di isolamento sono quasi finiti e spero di mettere a frutto il lavoro sul campo. Quando ho lanciato il crowdfunding che ha reso possibile questo viaggio, il racconto del conflitto nella Repubblica democratica del Congo era affidato a pochi giornalisti, limitato a rari reportage, a ricordare una guerra talmente protratta da non fare più notizia. Poi, la morte di Luca Attanasio, Mustapha Milambo e Vittorio Iacovacci sulla strada che collega la capitale della provincia del Nord Kivu, Goma, alla cittadina di Rutshuru, ha riportato – in particolare in Italia – l’attenzione su una terra che sembra sempre tanto lontana. Ero anche io su quella strada, con il Programma alimentare mondiale, solo qualche giorno prima.
Vorrei che l’attenzione restasse alta e questa è anche una responsabilità della stampa, che spero continui a trovare spazi per raccontare questo paese. Il crowdfunding è nato per questo, per non condannare il Congo, ed idealmente i paesi in conflitto, al silenzio.
Il Covid ha reso questo progetto più complesso e costoso. Gli spostamenti sono stati difficili, più di quanto già non lo siano in un paese senza strade e senza luce. Ho fatto cinque Covid test, preso otto aerei e lavorato a ritmi serrati perché le ore a disposizione sono poche e le condizioni di sicurezza impediscono di muoversi quando è buio: non si esce presto e alle sei è necessario essere in casa. Nonostante questo sono riuscita ad entrare nella quotidianità di un paese complesso e ho condiviso i rischi con le persone che ogni giorno vivono il conflitto sulla loro pelle. Non ho potuto fornire molti dettagli e aggiornamenti perché i rapimenti sono troppo frequenti: ho sempre cercato di muovermi con discrezione. Tutto quello che leggerete non sarebbe stato immaginabile senza la guida straodinaria di un collega di Goma, Akilimali Saleh Chomachoma.
Sono partita il 1 febbraio e tornata il 25, ho dovuto cambiare i miei programmi e restare a Kinshasa per raccontare della morte di tre uomini che ha ricordato al mondo questa guerra senza fine. Ma oggi il mio è solo un piccolo anticipo di questo viaggio. Il diario minimo della mia prima settimana.
Partire è stato difficile, e ci sono voluti due giorni per raggiungere Kinshasa. Il 1 febbraio dello scorso anno avevo preso l’ultimo volo, da Roma a Bristol, per un corso per giornalisti in ambienti ostili. I voli cancellati a causa della pandemia mi avevano costretto a posporre il viaggio, sino a data da destinarsi. Poi, proprio la pandemia mi ha convinta che non si doveva lasciare all’oblio una parte del mondo che aveva ancora bisogno di essere raccontata. All’aeroporto di Roma Fiumicino tutto è cambiato: solo un Terminal attivo, pochi viaggiatori e tanta confusione per la documentazione sanitaria. Volo via Parigi, come molte altre persone dirette in Africa. Al desk di Air France c’è chi non potrà imbarcarsi per la mancanza della documentazione richiesta negli aeroporti di arrivo. Passo la notte a Charles de Gaulle, aeroporto quasi spettrale.


Il viaggio verso Kinshasa è lungo. Volando sopra il deserto del Sahara e poi sulle foreste equatoriali, la bellezza del paesaggio è stupefacente. Eppure è impossibile non pensare che stiamo volando sopra un mondo di grande sofferenza. I paesi sotto i nostri piedi vivono tutti miseria e guerra, migliaia di chilometri di bellezza e tragedia, milioni di persone che meritano un futuro migliore. In questa geografia ci si sente piccoli, un piccolo punto al di là del Mediterraneo.

Mi sono portata i disegni dei miei nipoti. Facciamo un gioco insieme. Girano il mappamondo, chiudono gli occhi e mettono il dito su un paese a caso, e poi io gli racconto qualcosa di quel paese. Un giorno Giacomo, quando aveva sette anni, punta l’Afghanistan ed io gli parlo di ciò che mi sarebbe piaciuto vedere, non essendoci mai stata. I laghi blu di Band-e-Amir, per esempio. “Possiamo andarci zia?” “Un giorno, adesso ci sta la guerra”“Perchè invece di fare la guerra non fanno del turismo?” Domanda difficile, non banale, ma adatta a spiegare l’assurdo di un mondo che rinuncia a coltivare bellezza. Ogni volta mi piace pensare di poter tornare con un abbozzo di risposta.
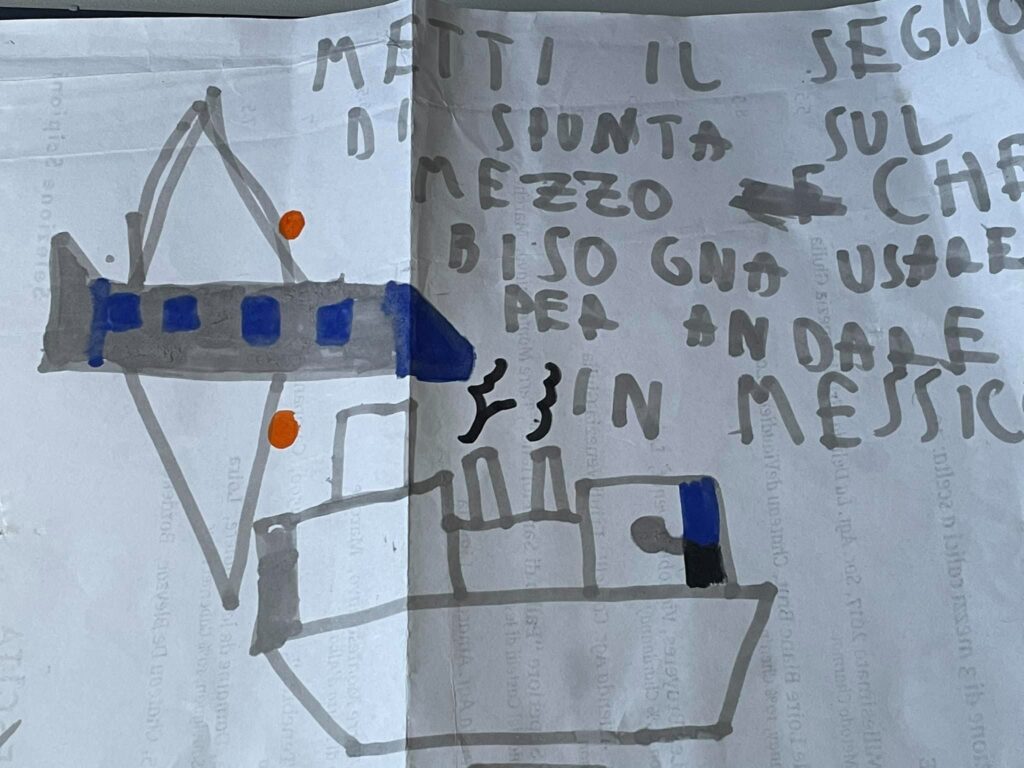
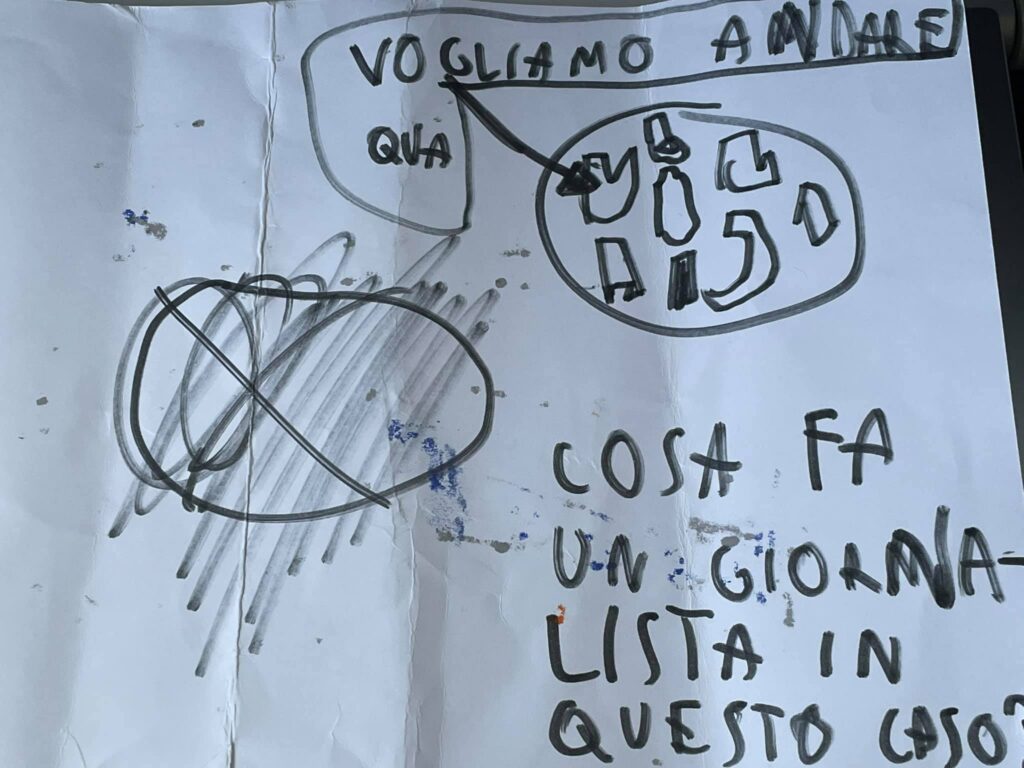
E poi, finalmente, il fiume Congo. Una delle più straordinarie visioni della mia vita. Non posso smettere di pensare a quell’incredibile crogiuolo di culture che sono fiorite lungo questo fiume: commerci, lingue. Il Congo non è solo guerra.

A Kinshasa resto alcuni giorni, per un altro test Covid e per incontrare l’Ambasciatore italiano, Luca Attanasio. Quel colloquio che ho avuto a Febbraio, e di cui ho raccontato su La Rpubblica, mi aveva fornito moltissimi spunti per lavorare, avevo custodito quegli appunti e verificato molte cose. Avrei usato quel materiale per il mio reportage, e pensavo di scrivere, una volta tornata, della nostra ambasciata a Kinshasa, di quello straordinario servizio che l’ambasciatore, il console Alfredo Russo e lo staff davano ai cittadini. Ho voluto raccontare di quell’incontro perché credo sia importante in questo mare di notizie che si stanno diffondendo, alcune prive di ogni fondamento. Questa che leggete è la persona che ho incontrato e l’impressione che ne ho avuto.
Kinshasa è una città di contrasti, che non ho tempo di esplorare. Circa 18 milioni di persone sulla riva sinistra del fiume Congo. Una megalopoli, Leopoldville fino a pochi anni dopo l’indipendenza. E’ costosa oltre ogni immaginazione. Quartieri poverissimi, senza luce, e con un livello altissimo di criminalità; strade affollate dove la gente vende di tutto; alberghi e auto di lusso, per una ricchezza che è di pochissimi. Su tutto, una luce magnifica.

Serve un tampone per imbarcarsi a Fiumicino, e poi un altro appena si atterra a Kinshasa, costa 45 dollari e vale sette giorni. Senza non si possono prendere voli interni, l’unico modo possibile per spostarsi in un paese vasto come il Congo. All’aeroporto si entra in un capannone, dove la calca non è poca. Il personale dell’INRB, l’Istituto nazionale di ricerca biomedicale, esegue il prelievo e poi si deve passare sotto una sorta di doccia che vaporizza del disinfettante. Due giorni di attesa e ci si può imbarcare di nuovo. Oltre ai test, il COVID sembra appartenere ad un altro mondo, o forse a quello della leggenda, perché in tanti qui credono non esista o al massimo non riguardi loro. Le strade gremite come sempre in Africa, qualche mascherina abbassata sul mento per strada, un distanziamento sociale difficile da rispettare, tranne nei luoghi pubblici dove invece le regole si rispettano e c’è spesso del personale che ti fa lavare le mani e usare il disinfettante.

Poi, si arriva Goma. La violenza sembra lontana nella downtown dove vive la comunità internazionale, a ricordarla, solo gli elicotteri dell’ONU. Ma dove vivo io la violenza è quotidiana. E’ bellissima Goma, affacciata sul lago, adagiata sulla terra nera, punteggiata dai colori dei fiori. I vulcani che hanno dato forma alla regione dei Grandi Laghi hanno reso questi luoghi fertili, dove ogni sorta di bellezza può crescere. Eppure, qui, la gente muore di fame.
Niente strade, acqua o luce. I quartieri più poveri di Goma sono quelli che sperimentano il più alto livello di insicurezza urbana. Le violenze avvengono di notte, ma i rapimenti anche di giorno. I villaggi nel Nord Kivu rurale bruciano per una guerra infinita che raggiunge i quartieri più occidentali della capitale della provincia. Il contrasto con il centro dove vive la Goma ricca ed internazionale è straniante.

Lava e legno, bellezza e dolore. Nel 2002 il vulcano Nyiragongo ha devastato la città, oggi la strada che da Goma guarda il monte e si inoltra nelle campagne, è un dedalo di case di legno e terra nera. Case troppo vulnerabili per proteggere le famiglie che le abitano.

I più vulnerabili sono i bambini, spesso vittime di rapimenti a scopo di riscatto, una delle attività attraverso cui gruppi armati e criminalità ordinaria di finanziano. Famiglie poverissime, costrette a vendersi le poche cose che hanno per liberare i loro cari. Accade, in pieno giorno, non lontano da questa scuola.

I rumori della notte non cullano e la casa non è dolce. La guerra sembra lontana nelle periferie di Goma, a ricordartelo ci pensano gli elicotteri della Monusco, I caschi blu dell’ONU. Ma è quando il buio improvviso precipita come ogni giorno all’Equatore, che l’inquietudine diventa abitudine. Dove la città finisce, ed ancora di più nei villaggi rurali, è spesso la notte a risuonare di spari, la notte a portare devastazione.
Così si addormenta l’Est.

C’è una cosa che mi hanno ripetuto in molti in questo viaggio: “La guerra distrugge la stima che le persone hanno di se stesse”, come se la brutalità subita fosse una colpa o una debolezza. Ricostruirla, è difficile. C’è chi a Goma ci prova, ogni giorno, coltivando talento e bellezza tra le vittime del conflitto. Vi racconterò le loro storie.

To be continued ….



